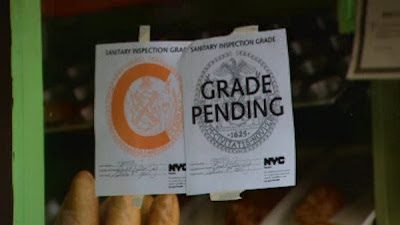Incredibile quanto poco durino le pratiche per il noleggio di un'auto in America.
Non che siano tanto differenti da quelle italiane (ci sono un bel po' di moduli da firmare anche qui), ma tutto si svolge in modo assolutamente rapido. Forse solo perché dietro ai banchi prenotazione ci sono sempre decine di impiegati.
Perché noleggiare un'auto, negli Usa, non è affatto un lusso, viste le tariffe applicate e la concorrenza fra tante agenzie di noleggio. Anzi, semmai a Manhattan è considerato quasi un lusso possederla, un'automobile, con il costo dei parcheggi che talvolta supera anche i 10-12 dollari l'ora (ma con 24 linee di metropolitana che funzionano 24/7 - 24ore su 24 e 7 giorni su 7 - che serve avere un'auto di proprietà?).
L'ufficio dell'Avis più vicino che avevo, era a dieci minuti a piedi da casa. E nemmeno dieci minuti impiegai per prenotare l'auto che avrei preso il giorno dopo. (La storia di Warren Avis la racconterò nel libro che vorrei pubblicare, se qualche dannatissimo editore si decidesse a farlo. Pagandomi, s'intende...).
Confesso che non mi dispiace fare il "grandeur": avrei, infatti, voluto un'auto enorme, gigantesca.
"Americana", insomma, tanto l'avrei noleggiata per un solo giorno.
Ma alla fine, più che la mia anima infantile prevalse il senso di colpa italico, che mi fece optare per il modello più piccolo.
L'indomani, quando mi presentai, ero dunque rassegnato a guidare un'auto poco più grande di una Smart: tipo Micra o Opel Corsa.
Sorrisi quando mi trovai, invece, di fronte a questa vettura...
Esatto: questa, per gli americani, è un'auto "small"...
Salii a bordo, presi bene il respiro per vincere la piccola emozione, allacciai la cintura, misi a punto la posizione del sedile e degli specchietti, attaccai al vetro il navigatore satellitare che mi ero portato dall'Italia, cliccai l'opzione "carta Stati Uniti", ed ecco che dopo qualche istante - con i grattacieli intorno l'aggancio al segnale è un po' più lento... - sul visore apparve la mappa dei cinque o sei isolati di Manhattan in mezzo ai quali mi trovavo.
E questo, quando accade in America, mi sembra ogni volta incredibile e mi procura un senso di infantile euforia.
Guidare negli Usa - l'ho già scritto - procura sensazioni difficili da descrivere: è come se al volante dell'auto noi italiani ci sentissimo un po' Cristoforo Colombo, un po' Amerigo Vespucci, pronti a spingerci oltre i confini conosciuti.
Lo so: sono il solito esagerato!
In realtà non è che dovessi andare molto lontano: il mio amico G. abitava, infatti, solo al di là del fiume Hudson, il corso d'acqua (colossale!) che separa New York e Manhattan con lo Stato del New Jersey.
Ansia? Un po', solo un po': in auto sarei stato solo, ma il funzionamento del navigatore mi confortava e rilassava (anche forse perché ero comunque munito di Atlante stradale...). Le amiche lettrici non possono capire, visto che vogliono sempre far di testa loro e cercare comunque un percorso alternativo a quello elaborato dal Gps... In genere, invece, un uomo obbedisce ciecamente ad un navigatore, considerandolo al pari della propria fidanzata, della propria compagna/moglie. Della quale si fida e alla quale si af/fida.
E così fu: io seguivo senza obiezione alcuna il mio fido Tom Tom che mi conduceva, street dopo street, verso il Lincoln Tunnel, una delle gallerie che insieme a vari ponti conducono fuori Manhattan.
Ok, avevo il navigatore, ma se guardate la cartina qui sopra - ma soprattutto la foto che segue - potrete facilmente intuire perché nonostante le precise indicazioni che ricevevo, ad un certo punto sbagliai strada.
Fui così costretto a fare due volte "il giro" di 'sta roba che vedete qui sotto, prima di trovare il percorso giusto per entrare nel tunnel. Ma non prima d'aver effettuato, ebbene sì, lo confesso, una di quelle che io definisco manovra "alla romana" .
Come oggi, mentre leggete, io non sia ancora là a vagare alla ricerca della giusta strada, non lo so...
Alla fine ce la feci.
Entrai in una delle tre gallerie costruite sotto il fiume fra il 1937 e il 1957, e notai che non c'era pedaggio da pagare. Scoprii che lo avrei pagato al ritorno, per "entrare" a Manhattan. Le autostrade, negli Usa, sono praticamente tutte gratuite, e nel raro caso di pedaggio si tratta di una tariffa irrisoria. Si paga spesso, invece, il passaggio su alcuni ponti (pratica che trovo un po' "medioevale", della serie "Un fiorino!"...) e, appunto, l'ingresso in alcuni tunnel.
Ognuna delle tre gallerie aveva due corsie (per la verità assai strettine...) che seguivano lo stesso senso di percorrenza. Ma mi pare d'aver capito che il senso di marcia della galleria centrale cambia secondo le ore di maggior traffico.
Dentro la galleria le indicazioni erano chiarissime: vietato, vietatissimo, ogni sorpasso o cambio di corsia; dove si entra, si resta.
L'indicazione "STAY IN LINE", "RESTA NELLA TUA CORSIA" la si poteva leggere ogni dieci metri...
Là dentro - anzi, là sotto - l'atmosfera, lo ammetto, era vagamente claustrofobica, sensazione che aumentava decisamente se mi soffermavo a pensare che sopra di me v'erano migliaia di tonnellate d'acqua di un fiume colossale, come ho già scritto. E quando lo definisco colossale non esagero, visto che il fiume Hudson - dalla punta sud di Manhattan (Battery park) al New Jersey - misura in larghezza quasi un chilometro e mezzo (!), precisamente 1548,42 yards.
Ma dovevo concentrarmi, soprattutto per evitare di passare la linea doppia continua e mantenere la distanza di sicurezza da chi avevo davanti tenendo la velocità costante, visto che il rigidissimo limite era di 35 miglia all'ora, 56 km orari. Mi rassicuravo pensando che percorere quei due chilometri e mezzo di galleria sarebbe stata solo una questione di minuti.
Sbucare dall'altra parte del fiume, arrivare in New Jersey, è stata per me una vera sorpresa:
perché ero partito circondato da una selva di grattacieli e palazzoni, mentre dopo pochi minuti mi trovavo ad attraversare paesaggi composti da piccoli paesini di villette mono-familiari, ognuna con il box doppio, il proprio prato curatissimo e, soprattutto (cosa che non smette di stupire noi italiani), senza alcuna recinzione, né sbarre alle finestre.
Prima di arrivare all'appuntamento, in uno di questi paesini vedo un cartello che mi incuriosisce.
Mi fermo e lo fotografo.
Verrò poi a sapere che negli Stati Uniti spacciare droga nei pressi di una scuola è un'aggravante.
O meglio, l'aggravante scatta se uno spacciatore viene pizzicato all'interno dell'area delimitata da cartelli come questo, che vengono posti in un raggio di circa mezzo chilometro dall'edificio scolastico, ma il limite varia da Stato a Stato.
Insomma, chi viene beccato da quelle parti a spacciare si vedrà automaticamente aumentare la pena di tre anni secchi.
Ma ci sono Stati americani dove gli anni di "aggravante" sono anche maggiori.
Poi arrivo.
L'appuntamento con G. è al Bar Sanremo di Hoboken.
Anche se non c'ero mai stato, riconosco il locale da lontano: sopra l'ingresso, accanto a quella americana sventola infatti la bandiera italiana. In questa parte di New Jersey gli abitanti di origine italiana forse sono davvero la maggioranza.
Ai tavolini del bar, due copie di America Oggi - il quotidiano in lingua italiana che si stampa negli Usa - la Gazzetta dello Sport e Tuttosport del giorno prima. La tv è sintonizzata su RaiUsa: vedere dall'America la Clerici con il suo grembiule che traffica in cucina, ammetto che fa un certo effetto...
Dietro alla vetrina del bancone, cannoli siciliani, cassate, babà e giganteschi maritozzi con la panna.
"Vuoi mangiare qualcosa?", mi viene chiesto. Sorrido: dovunque un italiano vada all'estero, c'è sempre questa fra le prime domande che si sente fare da un parente o da un amico (italiano, ovvio)...
Ci abbracciamo.
Quanto voglio bene a G....
E quanta emozione mi procura il calore degli immigrati italiani all'estero.
Mi presenta ai suoi amici ma, tempo di stingerci la mano e di sentirmi fare (le solite) domande sull'Italia, ho davvero l'impressione di essere loro amico da sempre.
Non resisto al cappuccino - caffè italiano, of course... - con il monumentale maritozzo alla panna (anche questa, ora, la posso confessare...); ma proprio in quel momento mi rendo conto di aver lasciato il portafoglio in bella vista nell'auto, sul sedile a fianco al mio, e scatto verso l'uscita per recuperarlo di corsa.
Mi fermano sorridendo: "Non siamo in Italia, qui. Nessuno te lo frega, anche se da fuori si vede, tranquillo...".
E io che un po' sorrido.
E un po' no...
Usciamo, e io e G. inziamo a parlare. Passeggiando, "il discorso" rimandato da tanto tempo viene fuori poco per volta, perché - mi dice - "non so come iniziare (e finire) la mia storia".
Mi dice che gli sembra come la Tela di Penelope.
"Non so come facciano gli altri emigranti a spiegare in due parole una cosa così complicata. Come facciano gli altri a descrivere ricordi, sensazioni, emozioni, paure, sogni..."
"Perché, mio caro, quello che può sembrare un capitolo coraggioso della mia vita, una scelta coraggiosa compiuta ad un certo punto della mia esistenza, una scelta che ha coinvolto anche la vita di altri, temo sia soltanto una banale scelta di 'viltà'.
E tutte queste sensazioni, questo senso di colpa, rimangono dentro come un macigno, come una pietra tombale".
"Dovrei iniziare da molto lontano...
Dovrei iniziare dalla prima parte della mia vita, dal paesino siciliano che ho lasciato. Dovrei raccontarti cosa rappresentava per me il mio paese.
Dovrei iniziare da quando ho dovuto abbandonare gli studi, la scuola che amavo tanto.
Dovrei parlarti del provino che avevo superato per giocare nel Perugia calcio, in serie A, dell'Università che avrei voluto frequentare, del futuro da sogno che avevo davanti...
Invece ti devo raccontare di quando avevo 17 anni e mi sono trovato una famiglia da mantenere facendo un lavoro che odiavo, in un ambiente che odiavo.
Ecco, dovrei inziare dalla mia famiglia.
Dovrei parlare di mia moglie che è stata la prima ragazzina che ho amato e che Dio ha voluto diventasse mia moglie...
Dovrei parlarti delle mie bambine, che ora sono donne fatte.
Dovrei parlarti della politica, così difficile da fare in Sicilia, del mio essere di sinistra e della mia militanza nel Pds, che anno dopo anno mi ha portato ad un certo punto a diventare segretario della sezione del mio paese.
Ma devo parlarti di quello che è successo quando mio padre è morto, e delle condoglianze che abbiamo ricevuto.
Devo parlarti di quelli che ci hanno mandato un biglietto tutto sgrammaticato con una frase del tipo 'Vi siamo vicini, capiamo che adesso per voi è difficile: allora passiamo ad incassare fra quindici giorni'.
E allora devo raccontarti dello sbalordimento mio e di mio fratello, che non sapevamo nulla, che non capivamo, che mai avremmo immaginato.
Devo raccontarti della nostra scelta di denunciare la cosa alla Polizia, di dire 'no', di non cedere all'arroganza, di non far finta di niente di fronte a quelle telefonate.
Che prima avevano toni gentili, quasi preoccupati, poi persuasivi, falsamente amichevoli, quasi fraterni, ma che presto arrivarano ad essere impazienti, poi aggressivi, poi minacciosi...
Dovrei parlarti delle mie continue crisi respiratorie che avevo in quel periodo e che non riuscivo a far andare via.
Poi dovrei descriverti il boato di una bomba, quella che ha distrutto l'ufficio che fu di mio padre e che con la sua morte avremmo dovuto gestire noi figli.
Dovrei raccontarti di quella volta che per cercar di capire come uscire da quella situazione, come se ci fosse stato qualcosa da capire, andai fino a Milano a discutere con un delinquente, una specie di boss, nel retro di un ristorante, in mezzo a donne mezze nude.
E io, cretino, che più che temere lui, ero terrorizzato all'idea di una retata improvvisa e a come diavolo avrei potuto spiegare a mia moglie perché mai mi trovavo lì, con tutte quelle donne nude intorno.
Io, che ero nipote di un capitano dei Carabinieri, uno dei collaboratori di Falcone e Borsellino: io cosa cazzo ci stavo a fare in quel posto, davanti a quello là, con quelle donne lì?
Allora dovresti anche sentire di quando vidi ammazzare un ragazzo davanti ai miei occhi, colpito in pieno petto quando era a meno di un metro da me. Era un mezzo delinquente, è vero, figlio di gente poco per bene, ma cadde davanti ai miei piedi proprio mentre io ero seduto tranquillo a una panchina in piazza, al paese.
E non è vero che quando viene colpita, una persona muore come nei film: a terra il corpo di quel ragazzo sobbalzava da solo, come investito da convulsioni.
O forse ti dovrei raccontare la morte di un bambino di otto anni ucciso per errore in uno scontro fra bande a Niscemi: ero amico della sua famiglia e ora c'è un monumento, in paese, a quel bambino...
Insomma, dovrei rivivere tutto questo.
E anche se mi fa male ritornare su quella prima parte della mia vita, forse dovrei finalmente parlarne...
Ma forse so anche che non ci riuscirò mai.
Ma che razza di vita era, quella? ".
Cari amici di Aria Fritta: erano anni che, io e G., nelle nostre chiacchierate giravamo attorno a questo argomento, ma io non avevo mai osato chiedere. Aspettavo che fosse lui ad aprirsi, a rendermi partecipe di questa parte della sua vita.
Della parte italiana della sua vita...
E allora lo ascoltai senza interromperlo. Perché in quel momento ebbi l'impressione che davvero non avesse parlato quasi con nessuno di queste cose.
E che invece, ora, il "momento" era arrivato.
Finalmente.
"E poi..."
"... E poi dovrei parlarti della seconda parte della mia vita...
Della scelta che facemmo di vendere ciò che ci aveva lasciato nostro padre e di andarcene via dalla Sicilia, e io in America.
Dovrei parlarti della scelta di non voltarmi più indietro.
Di non chiedermi cosa ne sarebbe stato di mia madre, di mio fratello, di mia sorella, della mia casa, del mio splendido paesino in riva al mare siciliano.
La scelta di azzerare tutto.
Dovrei parlarti della mia anziana nonna materna, che ormai era spesso poco lucida, ma che sorprendentemente mi riconobbe quando andai da lei la sera prima di partire. E allora, con lei seduta sulla sua sdraio, io mi inginocchiai ai suoi piedi per appoggiare la testa sulle sue gambe, come facevo da bambino.
Dovrei parlarti delle lacrime disperate che quella sera ho versato, con lei che, accarezzandomi la testa mi disse soltanto 'Vai via, vero? Non ti rivedrò mai più'...".
Dovrei parlarti di quando la baciai sulla fronte e me ne andai, con la morte nel cuore, e delle lacrime che abbiamo versato io e mia moglie, insieme, quella notte, nella nostra ultima notte italiana. E noi che avremmo lasciato la nostra casa, quel profumo di gelsomino e rose, e quella vista sul mare di Sicilia.
Com'era bella la nostra casa, Dario...
Dovrei parlarti di quell'ultima notte, quando con un filo di voce le dissi 'Possiamo restare, se vuoi...'. Ma era irremovibile, lei.
Come lo ero io...
Dovrei parlarti di quella mattina che partimmo senza voltarci, di quando abbiamo preso l'aereo a Catania e già mi sentivo più tranquillo.
Insomma, dovrei parlarti della mia fuga in America.
Della scelta di ricominciare tutto da zero.
Da capo.
E allora dovrei anche raccontarti degli anni che qui ho passato come 'clandestino'.
Sì, esatto: clandestino.
Qui sono più gentili che in Italia: qui una persona di questo tipo viene semplicemente definita 'illegal', 'illegale'; ma la sostanza è che sono stato, ero, un 'clandestino', uno senza un legale permesso di residenza e di lavoro.
Nonostante la solidarietà umana - il calore che ho ricevuto e la serenità che ho ritrovato qui, a migliaia di miglia dalla mia Sicilia - dovrei parlarti della paura quotidiana di essere beccato, di essere cacciato, di esser costretto a tornare in Italia...
Non mi sarei mai però avventurato qui, con moglie e bambine, se non avessi avuto una specie di piano: una casa dove vivere, un lavoro che mi aspettava.
Quando arrivai, fui subito preso in una pizzeria, e dopo un mese io e mia moglie eravamo già in grado di pagarci l'affitto per il nostro appartamento e a camminare con i nostri piedi.
Qui, in America, mi colpirono immediatamente gli odori, il senso di pulizia, il rispetto per la cosa pubblica, l'educazione e la sensazione di tranquillità e sicurezza.
E poi respiravo meglio, forse in tutti i sensi: e piano piano le mie crisi respiratorie scomparvero.
Tempo tre mesi e diventai appunto "illegale", come si dice qui.
Ho lasciato scadere l'autorizzazione del viaggio turistico. Sapevo che era una specie di passaggio obbligato della mia vita da emigrante. Ma c'era un avvocato che seguiva la mia pratica.
E io non potevo permettermi di tornare in Italia e rinunciare a vivere.
Guardavo però gli altri connazionali e subito mi rendevo conto di quello che non volevo diventare: c'era gente che non sapeva una parola d'inglese, che frequentava solo italiani: casa, e poi bar italiano, circolo ricreativo italiano, il campionato di calcio italiano la domenica...
Io mi iscrissi all'università, e non ero mica un ragazzino, sai? Mi sono iscritto a corsi di inglese per stranieri.
E mi trovai un lavoro extra a part time in un negozio di noleggio film, così vidi decine, centinaia di film in inglese...
Certo, ho attraversato momenti dolorosi, come la perdita di persone care in Italia.
O ho vissuto momenti di autentico panico, come quando al ristorante si presentarono due agenti dell'Fbi: e meno male che non eravamo noi ad essere sotto indagine...
Quando ero clandestino invidiavo i cani e gli uccelli che erano esseri liberi, e quasi disprezzavo i tossico e i delinquenti, perché - pensavo - non si meritavano il lusso di essere 'cittadini americani'.
Ma non ho mai avuto problemi: quando lavori e alla fine della settimana porti a casa i soldi che ti servono per tutto, e magari riesci anche a mettere da parte qualcosa, sei sereno.
Ed è questo quello che conta, nella vita, credo.
Poi, poco per volta, nella vita le cose si sistemano: un posto di lavoro con sponsorizzazione, e la domanda per la Green Card...
Uno dei momenti di assoluta felicità della mia vita fu quando la Green Card arrivò nella casella della posta di casa mia. E' stato uno dei momenti più belli della mia vita. Una sensazione di felicità che avrei pensato di poter riprovare solo se io fossi riuscito a tornare all'innocenza dell'adolescenza.
Oriana Fallaci ha scritto che per lei l'America era "un amante al quale lei sarebbe stata sempre fedele, mentre l'Italia era sua mamma".
Ecco, io sento esattamente la stessa cosa.
Ma non mi chiedere di cosa penso dell'Italia, vista da qui.
Il mio idolo, in Italia, era Sandro Pertini.
Sono sempre stato di sinistra, socialista, amo l'Italia, ma davvero non riesco a sopportare la politica italiana di oggi.
Vista da qui, con il distacco favorito dalla distanza, la politica italiana la trovo rivoltante.
Dovrei parlarti di tutte le volte che ai miei cari ho detto 'Ma sì, dai, probabilmente verrò l'anno prossimo, in Italia...'.
E invece ne sono già passati 15 di anni, ormai.
E loro che adesso me lo chiedono sempre di meno, quando mi farò rivedere.
E' che io ho paura di scalfire il mio ritrovato equilibrio, la mia pace con il mondo.
La pace e la tranquillità che ho trovato qui, Dario.
Bada bene, tutto questo ha avuto un costo altissimo: la solitudine, la paura, la fatica di fare due lavori contemporaneamente, quella di aprire la mia pizzeria e poi di chiuderla per una sensazione che sentivo nell'aria, prima che se la potesse mangiare la crisi.
Tutto questo oggi lo definirei 'un salto pazzesco di razionale pazzia'.
Perché non pensare che io non sogni il mio mare, il profumo del pesce e del pane del mio paese.
Mi incanto sempre a guardare le foto del mio paesino siciliano in riva al mare...".
Però? Gli chiedo...
Però?
"Però oggi mi sento bene, Dario.
Finalmente.
Oggi mi sento sereno.
E libero.
In un Paese dove basta rispettare la legge e lavorare, per migliorare la tua vita. Quella tua, della tua famiglia e dei tuoi figli".
Il discorso scivola sul giorno del suo giuramento.
Già, perché da qualche mese, infatti, il mio amico G. è diventato cittadino americano.
E a ricordare quel giorno gli luccicano gli occhi.
"Come mi batteva all'impazzata il cuore in quel momento, quando con tutte quelle persone ho recitato ad alta voce la formula del giuramento, con la mano destra alzata, insieme a tutta quella gente con gli occhi lucidi e la pelle di tutti i colori, noi, "miserabili rifiuti dei vostri lidi affollati", come c'è scritto alla base della Statua della Libertà.
Non mi vergogno a dirtelo, sai?, ma io - dopo aver giurato e dopo aver ricevuto il diploma da 'americano' insieme ad una copia della Costituzione e ad una bandierina americana - uscito dalla sala, ho pianto.
Ho pianto come un disperato fra le braccia di mia moglie.
Ho pianto come un bambino.
Ma dopo - proprio come succede ai bambini, dopo un pianto disperato - mi sono sentito leggero.
Libero.
Sereno.
Lontano".
Mamma mia...
Mamma mia, cari amici di Aria Fritta.
Mi fermo per qualche istante. Devo riprendere fiato.
Poi ridiamo anche, però: come quando mi racconta della sua patente ottenuta pur essendo illegale.
Fece la domanda lo stesso, consegnandola però ad una impiegata che - aveva notato guardando la spilla di riconoscimento - aveva un cognome italiano. Lui riconobbe immediatamente l'accento siciliano di lei e allora iniziarono a parlare dialetto.
G. fu sincero, e in siciliano, appunto, sottovoce le disse di avere "bisogno della patente per poter lavorare".
Con lei, allora...
Con lei che in silenzio per qualche decina di secondi lo guardò bene e fisso negli occhi, per poi prendere sempre in silenzio il modulo grazie al quale poi G. fece l'esame di guida.
E con un leggero, impercettibile, sorriso, ci mise un timbro sopra.
Un po' come "Il pescatore" di Fabrizio de André.
Ci facciamo una foto insieme e poi ci salutiamo abbracciandoci, come fanno gli amici di sempre.
Come lo saremmo stati ancora di più, d'ora in poi.
Penso a quell'assurdità che lui mi ha detto all'inzio: quando si è definito "vile" per la scelta che ha fatto.
Avrei voluto picchiarti, G, prenderti a schiaffi, darti un pugno, proprio come un amico picchia un amico che dice una cazzata gigantesca contro se stesso. Ma forse avrei solo dovuto semplicemente citarti la frase dello scrittore francese Henry Laborit: "In tempi come questi la fuga è l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare".
...
Poi me ne vado.Salgo in auto con un nodo alla gola, e con nelle orecchie la frase con la quale Salvatore, uno dei miei nuovi amici americani, mi ha salutato: "Ora che sai la strada puoi ritornare...".
Metto in moto e me ne vado con gli occhi gonfi di emozioni e la gola che mi esplode.
Accendo la radio a tutto volume, la sintonizzo su una stazione di musica country e parto senza far caso alla direzione.
Vado a zonzo per un'oretta per le strade del New Jersey, attraversando paesini ordinati e tranquilli, con le casette ai bordi della strada, senza muri attorno o recinti, senza traffico, e circondate da colline dolci.
Dopo aver fatto benzina compro una Coca Cola che sorseggio guardando un ruscello che passava davanti ad una fila di villette, semplici ma bellissime.
Le indicazioni per l'Interstate diretta a New York mi fanno passare ancora in mezzo ad altri piccoli paesi, con un incredibile numero di bandierine italiane appese fuori dalle casette da un piano e mezzo.
Sorrido con affetto di quell'orgoglio italiano.
E' lì, in quel momento, che - dopo anni di viaggi in America - arrivai alla conclusione che, davvero, forse l'unico modo per amare l'Italia è starne lontani.
Mi infilo nella Interstate, e dopo un'altra oretta di autostrada, da lontano, vedo New York tutta illuminata che mi aspetta.
E' notte, ormai.
E alla radio, gli Eagels cantano la loro "Desperado"...
***
Questo racconto, questa storia (vera), la scrissi il 14 febbraio 2013, 11 anni fa, sei mesi dopo l'incontro con il mio amico Giorgio.
Impiegai infatti qualche mese a smaltire quel carico di emozioni, prima di scrivere.
Giorgio, che - per motivi facilmente intuibili - allora chiamai solo "G." per una sorte di scrupolo, di protezione, ecco.
Da allora sono cambiate tante cose, per il mio amico G.
Come mi aveva preannunciato, ad un certo punto - qualche anno fa, raggiunti i requisiti dell'età pensionabile - Giorgio e la moglie decisero di tornare in Italia, nella loro Sicilia.
Una scelta, anche quella, in qualche modo lacerante, visto che una delle due sue figlie - ormai adulta - decise di rimanere negli Stati Uniti, mentre l'altra non se la sentì di restare in America e aveva già deciso di tornare in Italia.
Andando però ad abitare in Veneto, dove già viveva uno zio.
Giorgio, invece, rientrò nel suo (potenzialmente bellissimo) paese siciliano, da dove era partito.
Un piccolo paradiso, una piccola frazione in riva al mare, però non poco trascurata.
Tormentata quotidianamente da roghi illegali di discariche abusive che ne avvelenano l'aria, oltre a deturpare il paesaggio: le maledette "fumarole".
Tornato al paese, quell'incuria e quel vandalismo quotidiano erano diventati il suo tormento.
Perché i rifiuti (con i successivi roghi) che avvelenavano l'aria, non cessavano (e non sono cessati): nonostante le numerose denunce sui social, gli ovvi esposti alle Autorità, le petizioni e manifestazioni pubbliche di un gruppo di cittadini onesti che avevano formato anche una associazione.
"Sono un continuo crimine a cielo aperto", mi scrisse disperato lo scorso settembre, "ma qui sembra non interessare a chi ha responsabilità. Non è giusto, Dario".
Non sapevo cosa rispondergli.
Gli dissi solo "Giorgio, mi raccomando, sii solo prudente".
Con lui che mi rispose "Non si può restare inermi, è nella mia natura, lo sai... Ma sì, certo, starò attento. Grazie, Dario".
Il 17 dicembre, un mese fa, improvvisamente il cuore affaticato di Giorgio - dopo una vita trascorsa a spezzarsi la schiena negli Stati Uniti - non ha retto e ci ha lasciato.
Giorgio, il mio amico Giorgio, è così morto in Sicilia, come lui avrebbe voluto.
Anche se maledettamente troppo presto, a 64 anni.
Sono giorni che non riesco a darmi pace...
Mi piace ricordarlo così, pensieroso e solitario, in una delle sue ultime foto fattegli da una delle sue figlie, al tramonto davanti al meraviglioso mare della sua Scoglitti.
A pensare al futuro.
Al suo domani.
Che è stato troppo breve, maledizione.
© dario celli. Tutti i diritti sono riservati.